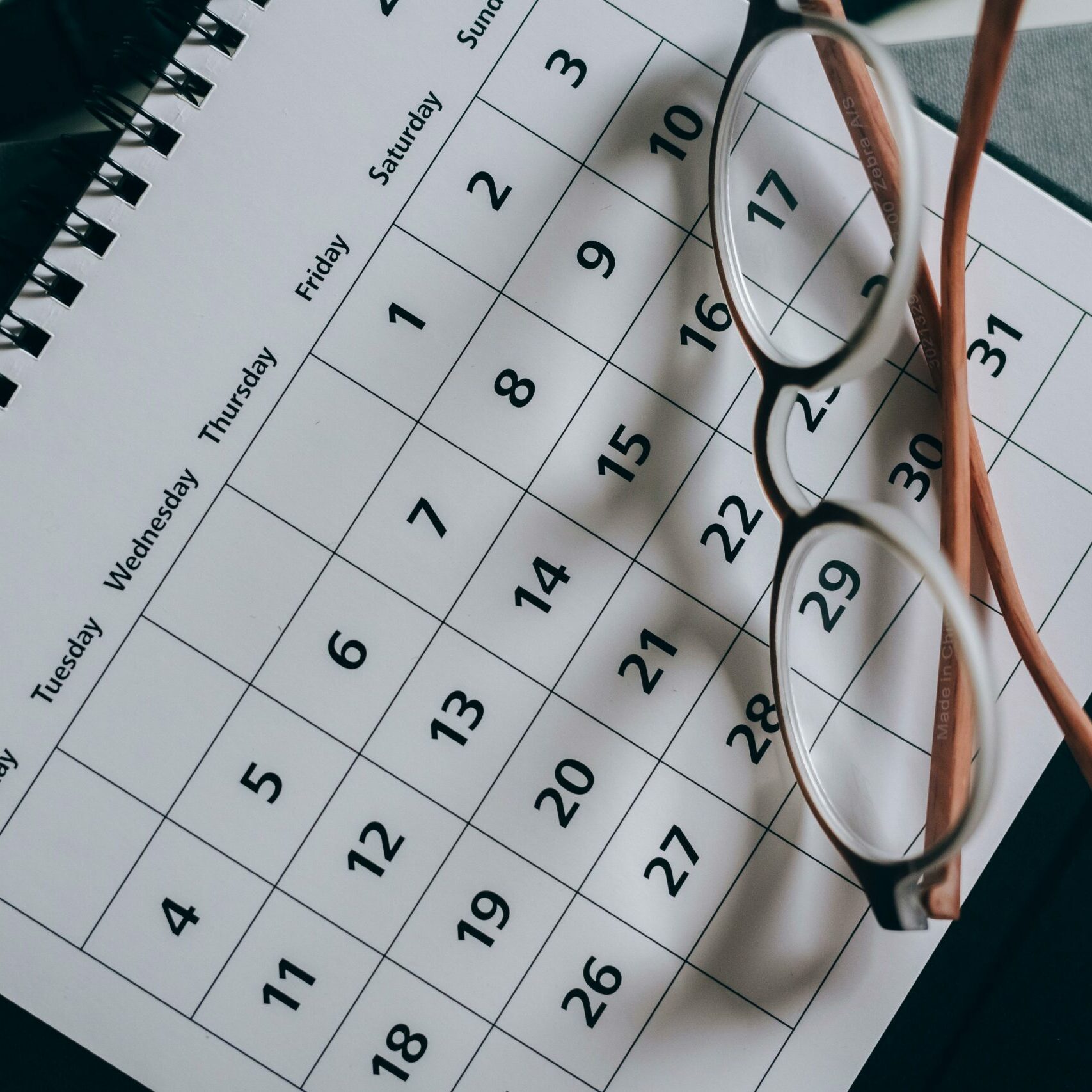Crediti d’imposta inesistenti vs non spettanti: cosa cambia nel 2025 (e cosa aspettarsi nel 2026)
La distinzione tra crediti d’imposta “inesistenti” e “non spettanti” orienta oggi sanzioni, termini e perfino i profili penali delle indebite compensazioni. Dopo l’intervento delle Sezioni Unite a fine 2023, il D.Lgs. 87/2024 ha unificato le definizioni tra amministrativo e penale; nel 2025 l’Atto di indirizzo MEF ha precisato i requisiti che fondano l’inesistenza, con un approccio sostanziale sganciato dai meri controlli automatizzati. In questo approfondimento (aggiornato al 2025 e con prospettiva 2026) spieghiamo come si qualificano oggi i crediti, quali sanzioni si applicano (25% per i non spettanti, 70% per gli inesistenti con aggravante 105–140% in caso di frode documentale), come leggere i termini di recupero e come impostare difesa e compliance.
Sommario esecutivo 2025 – in 10 punti (con proiezioni sul 2026)
Prima di entrare nel dettaglio, una mappa operativa per chi deve decidere subito.
- Definizioni unificate: dal 2024 la nozione di credito inesistente è la stessa in amministrativo e in penale; scompare il riferimento alla “rilevabilità” via 36‑bis/36‑ter/54‑bis.
- Criterio sostanziale: è inesistente ciò che non integra i requisiti costitutivi (oggettivi/soggettivi) della disciplina istitutiva o ciò che è fondato su rappresentazioni fraudolente (documenti falsi, simulazioni, artifici).
- Non spettante: è il credito che esiste in astratto ma è usato male (modalità/tempi/quantità) o fondato su fatti che, pur non toccando i requisiti costitutivi, non rientrano nel perimetro della norma istitutiva; include anche l’utilizzo in difetto di adempimenti a pena di decadenza.
- Sanzioni amministrative: 25% per i non spettanti; 70% per gli inesistenti; se l’inesistenza deriva da frode documentale, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio (→ 105%–140%).
- Penale (art. 10‑quater): soglie 50.000 €/anno; cornici edittali differenziate per non spettanti (comma 1) e inesistenti (comma 2); introdotta non punibilità in caso di oggettiva incertezza tecnica sulla spettanza (comma 2‑bis).
- Retroattività: le definizioni 2024 hanno natura interpretativa; nel 2025 la giurisprudenza le applica ai periodi pregressi, fermo restando il quadro sanzionatorio ratione temporis.
- Tempi di recupero: binari diversi per inesistenti vs non spettanti; in linea generale, tempi più lunghi per gli inesistenti. Verificare sempre il periodo e le norme transitorie.
- Atto MEF 2025: chiarisce che i requisiti costitutivi possono riguardare soggetto e oggetto dell’agevolazione e derivano da fonti primarie e secondarie esplicitamente richiamate; manuali/linee guida non richiamate non bastano da sole a fondare l’inesistenza.
- Compliance by design: serve una matrice requisiti‑prove per ogni credito (es. R&S, 4.0, Sud, Transizione green), con evidenze su progetto, tempi, spese e qualifiche.
- 2026 outlook: salvo interventi correttivi, l’impianto unificato resterà in vigore; attesi affinamenti pratici su atti di recupero e gestione delle incertezze tecniche.
Cronologia ragionata (2023 → 2024 → 2025 → 2026)
Comprendere la sequenza e le norme legislative recenti, potrà aiutarti ad impostare la tua strategia difensiva e la gestione dei rischi.
- 2023 (dicembre) — Le Sezioni Unite civili ricompongono il contrasto: per “inesistente” servono mancanza del presupposto (o creazione artificiosa/estinzione) e non rilevabilità dell’anomalia con i controlli automatizzati/formali; altrimenti si parla di non spettante.
- 2024 (giugno) — Entra in vigore il D.Lgs. 87/2024 che codifica (anche per il penale) la definizione di inesistente: focus sui requisiti costitutivi e sulle rappresentazioni fraudolente, senza più l’aggancio ai controlli automatizzati.
- 2024 (settembre) — La Cassazione riconosce natura interpretativa alle nuove definizioni: applicazione retroattiva ai periodi precedenti.
- 2025 (luglio) — L’Atto di indirizzo MEF n. 18 precisa che i requisiti possono derivare anche da fonti secondarie solo se espressamente richiamate dalla legge istitutiva; esclusa autonoma valenza a manuali e linee guida non richiamati.
- 2026 (prospettiva) — In assenza di riforme, resta la unificazione definitoria e il doppio binario sanzioni/termini. Possibili chiarimenti amministrativi su: criteri di incertezza tecnica, onere della prova su non spettanti vs inesistenti, criteri per riduzioni e definizioni.
Definizioni operative: cosa è “inesistente” e cosa è “non spettante” nel 2025
Perché questa parte è importante:
La qualificazione determina quale sanzione si applica, quali termini decorrono e quale strategia difensiva adottare. Qui fissiamo i concetti con taglio pratico.
1) Credito inesistente (oggi)
- Concetto: mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi fissati dalla disciplina istitutiva oppure tali requisiti sono rappresentati in modo fraudolento (documenti falsi, simulazioni, artifici).
- Esempi tipici:
a) credito “creato” in F24 senza base normativa/documentale;
b) progetto/attività che non rientra nei tratti costitutivi dell’agevolazione (es. R&S priva di novità/risultato come definito dalla norma; “Formazione 4.0” senza requisiti soggettivi dei lavoratori; “Investimenti 4.0” senza interconnessione);
c) condotta fraudolenta con documenti ideologicamente/materialmente falsi o con catene simulate.
2) Credito non spettante (oggi)
- Concetto: il credito esiste in astratto, ma è stato utilizzato in modo difforme (quantità/tempi/modalità) o fondato su fatti che non integrano ulteriori elementi richiesti dalla disciplina pur in presenza dei requisiti costitutivi; rientrano anche gli utilizzi in difetto di adempimenti espressamente previsti a pena di decadenza.
- Esempi:
a) utilizzo in misura eccedente il plafond;
b) fruizione anticipata/tardiva rispetto a finestre temporali;
c) mancata comunicazione “a pena di decadenza” dove prevista;
d) errori di calcolo su spese ammissibili fermo restando il possesso dei requisiti costitutivi.
Nota di metodo
La differenza non è più come l’Amministrazione scopre l’anomalia (automatizzati/formali vs sostanziali), ma cosa manca o è falsato alla radice del credito.
Effetti pratici nel 2025 (e oltre): sanzioni, aggravanti, riduzioni
Le scelte difensive e di compliance dipendono da un set di regole matematiche. Qui le sintetizziamo con esempi numerici.
Sanzioni amministrative “core”
- Non spettanti → 25% dell’importo utilizzato in compensazione.
- Inesistenti → 70% dell’importo utilizzato in compensazione.
- Aggravante “frode documentale” (per gli inesistenti): la sanzione del 70% è aumentata dalla metà al doppio → 105%–140%.
Esempio
Compensi 100.000 € con credito poi qualificato inesistente:
- base 70% = 70.000 €; con aggravante +50% → 105.000 €; con aggravante +100% → 140.000 €.
Coordinamento penale (art. 10‑quater)
Perché rileva
La qualificazione amministrativa riflette il penale: oltre le soglie, scattano i delitti di indebita compensazione.
- Non spettanti > 50.000 € annui → reclusione 6 mesi – 2 anni.
- Inesistenti > 50.000 € annui → reclusione 1 anno e 6 mesi – 6 anni.
- Non punibilità: esclusa la punibilità per i non spettanti quando sussiste oggettiva incertezza tecnica su “elementi/qualità” che fondano la spettanza del credito (nuovo comma 2‑bis); valutazione caso per caso.
Riduzioni e definizioni
- Ravvedimento: possibile nei limiti; torna utile per non spettanti con errori procedurali rimovibili.
- Accertamento con adesione / definizioni agevolate: leve per chiudere con sanzioni ridotte.
- Particolare tenuità del fatto e cause non imputabili: istituti che nel 2025 possono incidere sull’esito penale (omessi versamenti, ecc.).
Tempi di recupero e decadenze: come leggerli nel 2025–2026
I termini cambiano a seconda della qualificazione e della norma speciale che disciplina l’atto di recupero per il credito in questione. È dunque essenziale mappare periodo d’imposta e regola transitoria.
- Regola di massima: per i crediti inesistenti l’ordinamento prevede in genere termini più lunghi (es. fino all’ottavo anno in talune fattispecie speciali), mentre per i non spettanti trovano applicazione termini più brevi (es. in linea con i normali termini di accertamento).
- Decorrenza: attenzione alla data della violazione (es. compensazione in F24) e al dies a quo della decadenza previsto dalla norma speciale; le modifiche entrate in vigore dal 1° settembre 2024 impattano gli atti relativi a fatti successivi a tale data, fermo restando quanto segue.
- Retroattività definizioni: nel 2025 la giurisprudenza considera interpretative le definizioni del 2024; non si trascinano, però, automaticamente le nuove misure sanzionatorie su fatti antecedenti (salvo i principi generali del favor rei e le norme specifiche).
- 2026: salvo riforme, atteso consolidamento dei binari, con prassi più dettagliate su decorrenze e calcolo dei termini per singoli crediti agevolativi.
Tip pratico: inserisci nel fascicolo di pratica una timeline completa (delibere, progetti, perizie, comunicazioni, interconnessioni, utilizzi in F24) per ancorare con precisione dies a quo e norma di riferimento.
Onere della prova nel 2025: chi deve dimostrare cosa
Molti contenziosi si giocano sulla prova: cosa deve dimostrare l’Ufficio e cosa il contribuente.
- Ufficio: deve motivare il collegamento tra il fatto contestato e la mancanza (o falsità) di requisiti costitutivi per l’inesistente, oppure l’uso difforme per il non spettante.
- Contribuente: deve dare prova positiva dei requisiti costitutivi (per evitare l’inesistente) o, in alternativa, della corretta modalità di fruizione (per evitare il non spettante).
- Buona fede/certezza tecnica: nel 2025 contano le evidenze (documenti, perizie, tracciabilità) più delle opinioni; l’incertezza tecnica va dimostrata con fonti qualificate, non con prassi interne generiche.
Matrice requisiti‑prove per i crediti più sensibili
Non tutti i crediti hanno lo stesso profilo di rischio. Per alcuni, la linea tra “esiste/non esiste” si gioca su elementi tecnici. Proponiamo matrici essenziali (esempi da adattare).
A) Ricerca & Sviluppo
- Requisiti costitutivi: novità/creatività, incertezza scientifica/tecnica, sistematicità del processo, documentazione del progetto, qualifiche del team.
- Prove utili: progetto ex ante, piani di lavoro, milestone, deliverable, repository codice, perizie/valutazioni tecniche indipendenti, tracciabilità ore/spese.
- Rischi tipici: confusione tra R&S e mantenimento/customizzazione; affidamento a manuali non richiamati dalla norma; documentazione ex post.
B) Investimenti “4.0”
- Requisiti costitutivi: interconnessione, integrazione nei sistemi aziendali, caratteristiche tecniche minime, entrata in funzione.
- Prove utili: schede tecniche, log di interconnessione, perizie giurate, test di integrazione, fotografie/registrazioni, report ICT.
- Rischi tipici: macchinari non realmente interconnessi, dichiarazioni standard senza riscontri, upgrade parziali spacciati per full compliance.
C) Formazione 4.0
- Requisiti costitutivi: coerenza piani formativi, profili soggettivi dei discenti, erogazione e tracciabilità della didattica, valutazioni finali.
- Prove utili: registri presenza, piattaforme LMS, attestati, questionari, registrazioni sessioni, dossier per audit.
- Rischi tipici: ore non tracciate, mix figurativo tra training on‑the‑job e corsi, docenza non qualificata.
D) Transizione green/energia
- Requisiti costitutivi: parametri tecnici misurabili (es. efficienza, emissioni), rispetto di standard e certificazioni richiamate dalla norma.
- Prove utili: schede prodotto, certificazioni, misurazioni strumentali, rapporti di prova, fotografie/filmati.
- Rischi tipici: standard non richiamati dalla fonte primaria; perizie ex post.
Come usare la matrice: per ogni credito, crea un fascicolo digitale con indice: Requisiti → Evidenze → Soggetti responsabili → Tempistiche → Eventuali incertezze.
Casi pratici (anonimizzati) — come cambia la qualificazione
Ecco alcuni esempio che ti aiuteranno a capire dove passa la linea tra “inesistente” e “non spettante”.
Caso 1 — R&S senza incertezza tecnica
Scenario: impresa IT compensa 400.000 € per progetti “di innovazione”. Dossier privo di ipotesi sperimentali, documentazione ex post.
Esito 2025: qualificazione inesistente (mancano requisiti costitutivi).
Sanzione: 70% (→ 280.000 €), 105–140% se emergono documenti falsi.
Difesa: difficile senza perizia tecnica; si può lavorare su incertezza tecnica solo se seriamente documentata.
Caso 2 — 4.0 con interconnessione tardiva
Scenario: credito su beni 4.0 correttamente classificati; interconnessione avviene dopo l’utilizzo in compensazione.
Esito 2025: non spettante (il credito esiste ma usato in anticipo).
Sanzione: 25%.
Difesa: possibili definizioni agevolate; rafforzare protocolli interni su go‑live e prove di interconnessione.
Caso 3 — Credito “F24‑made”
Scenario: credito “generato” direttamente in F24 senza alcun titolo.
Esito 2025: inesistente a prescindere dalla rilevabilità automatica.
Sanzione: 70% (105–140% con frode).
Difesa: pressoché nulla se i fatti sono pacifici; focus su rateazione, su eventuali profili penali e su prevenzione futura.
Caso 4 — Formazione 4.0 con ore non a pena di decadenza
Scenario: requisiti sostanziali presenti; mancano taluni adempimenti non previsti a pena di decadenza.
Esito 2025: può rientrare nei non spettanti solo se la norma pretende quell’adempimento a pena di decadenza; altrimenti rilievo formale con rimedi.
Sanzione: 25% (se non spettante) o riduzioni in caso di regolarizzazione tempestiva.
Strategia difensiva 2025 (con check operativo)
Una buona difesa nasce prima del contenzioso. Ecco un percorso in 8 passi.
- Mappatura credito: identifica fonte primaria e secondarie richiamate; elenca i requisiti costitutivi e gli eventuali adempimenti a pena di decadenza.
- Gap analysis: verifica cosa manca (requisito vs modalità/tempo); se manca un requisito costitutivo → pista inesistente.
- Fascicolo evidenze: prepara contratti, perizie, report tecnici, comunicazioni, timeline utilizzi F24.
- Quantificazione rischi: simula sanzioni e interessi (25% vs 70%/105–140%).
- Penale: se > 50.000 €/anno, valuta impatto 10‑quater, possibilità di non punibilità per incertezza tecnica.
- Contraddittorio: presidia i termini; presenta memorie ben strutturate (fattuale + diritto).
- Definizioni: valuta adesione, rateazioni, strumenti deflattivi; calcola il costo‑beneficio del giudizio.
- Finalizzazione: correggi processi e controlli per evitare recidive.
Errori da evitare (2025)
Introduzione
Anche chi ha buone ragioni può indebolire la propria posizione con scelte sbagliate.
- Confondere requisiti costitutivi con adempimenti non essenziali: cambia tutto (70% vs 25%).
- Ignorare le fonti richiamate dalla norma istitutiva: possono essere decisive per dire “esiste/non esiste”.
- Affidarsi a manuali/linee guida non richiamati dalla legge: non bastano a fondare l’inesistenza (e spesso nemmeno la spettanza).
- Trascurare i transitori: dal 1/9/2024 cambiano le misure sanzionatorie; attenzione al ratione temporis.
- Non coordinare tributario e penale: rischi di contraddizioni e perdita di leve (es. non punibilità per incertezza tecnica).
Q&A (aggiornate al 2025, con note per il 2026)
Introduzione
Risposte brevi alle domande più frequenti; ogni caso richiede una verifica ad hoc.
1) Un credito “generato” in F24 è sempre inesistente nel 2025?
Sì, perché la modalità di scoperta non rileva più: se mancano i requisiti costitutivi (o c’è frode), è inesistente.
2) Ho tutti i requisiti ma ho usato il credito in anticipo: è non spettante?
Di regola sì: il credito esiste ma è stato utilizzato fuori dalle modalità/tempi → 25%.
3) L’aggravante 105–140% si applica a tutti gli inesistenti?
No, solo quando la inesistenza deriva da rappresentazioni fraudolente (documenti falsi, simulazioni, artifici).
4) Le definizioni 2024 valgono anche per fatti 2021–2023?
Nel 2025 sono considerate interpretative e dunque applicabili; la misura numerica delle sanzioni, però, segue il tempo del fatto (salvo favor rei).
5) Cosa aspettarsi nel 2026?
Continuità dell’impianto; possibili chiarimenti su incertezza tecnica, su fonti secondarie e sull’uso di perizie per la prova della spettanza.
Governance & controlli interni (2025–2026)
L’assetto organizzativo fa la differenza tra una pratica difendibile e una perdita certa.
- Ruoli: nomina un referente crediti e un controllo interno indipendente; coinvolgi il DPO per gli aspetti privacy.
- Procedure: istruzioni operative per raccolta evidenze e rinnovo annuale dei dossier; calendario cut‑off prima dell’utilizzo in F24.
- Formazione: sessioni mirate per finanza, tecnico, legale; checklist dedicate per credito.
- Audit: campionamenti periodici; report al CdA con indicatori (es. % pratiche con perizia; tempi tra interconnessione e utilizzo).
- Digitalizzazione: repository centralizzato, versioning documenti, firme elettroniche, log di accesso; preparazione a eventuale ispezione.
Conclusione
Nel 2025 la bussola è chiara: la distinzione tra inesistente e non spettante ruota intorno ai requisiti costitutivi e non più ai canali di scoperta. Questo rende più semplice la qualificazione (e più rigorosa la prova), ma consente anche strategie difensive mirate: se il credito esiste, lavorare su modalità/tempi e adempimenti; se non esiste, valutare subito definizioni, rateazioni e presidi per il penale. Guardando al 2026, l’impianto appare destinato a stabilizzarsi, con prassi che dettaglieranno incertezza tecnica, termini e oneri probatori.
Come possiamo aiutarti:
Se stai ricevendo un atto di recupero o vuoi impostare una due diligence difensiva sul tuo portafoglio crediti, il team BCFM Tax & Legal può supportarti con:
- Classificazione del credito (inesistente vs non spettante) e verifica dei requisiti costitutivi;
- Calcolo sanzioni/termini e analisi ratione temporis;
- Memorie e gestione del contraddittorio;
- Contenzioso e coordinamento penale (art. 10‑quater);
- Set‑up governance e modelli di controllo per il 2025–2026.
Contatti: 📩 info@bcfm.legal · ☎️ +39 02 5656 7295 (o box di contatto)